L’invenzione del pastore nella razzializzazione dei sardi
di Andria Pili

-“Se siamo una terra per turisti, e noi siamo una razza di pastori, dobbiamo essere i pastori, ma per i turisti”
-“Una razza nuova di pastori camerieri?”
(…)
-“O babbo, tutt’e due le cose bisogna fare adesso qui per i turisti, perché piacciono a loro certe cose, fatte così all’antica qui da noi. Noi com’eravamo, per loro siamo belli”
(da “Assandira” di Giulio Angioni, Sellerio 2004)
La proiezione di “Assandira”, film di Salvatore Mereu in concorso al festival di Venezia, ha portato recentemente nelle sale il tema dell’autorappresentazione dei sardi (“sembrare senza essere”) e della (re)invenzione della “identità sarda” a uso turistico (“più nuova ma antica, però vera”). La pellicola è tratta dal noto romanzo di Giulio Angioni, antropologo molto critico verso l’ossessione identitaria degli ultimi decenni come dei luoghi comuni sui pastori sardi, facenti da perno alla sardità immaginata. La storia narra della costruzione di un agriturismo volto a mettere in scena la figura stereotipata del pastore, per compiacere i turisti del Nord Europa (“Qui lo facciamo noi l’agriturismo veramente sardo pastorale, genuino, per la gente del Nord, prima che vengano loro, dal Nord, a metterci in mastruca ai loro ordini”). Il “vecchio” Costantino Saru, spinto dal figlio Mario e dalla nuora danese Grete, funge da “certificato di garanzia” dell’autentica “memoria storica ed etnica” sarda, esibendosi come pastore tradizionale, conciato in modo più somigliante a suo nonno che a lui; superata la riluttanza iniziale, sarà poi travolto dalla vergogna per aver trasformato in un “gioco” un modo di vivere molto serio. Anche Mario reciterà la parte del pastore, inventandosi tale pur non avendo mai svolto realmente questo lavoro: ogni mattina accoglierà i clienti, fingendo di aver dormito in mezzo alle pecore.
“Assandira” è ricco di spunti di riflessione. In un capitolo del libro – non reso al cinema – abbiamo la strumentalizzazione dell’identità da parte della politica. Politici regionali e provinciali partecipano all’inaugurazione dell’agriturismo, che è stato finanziato anche con contributi regionali a fondo perduto. Dal palco si parla diffusamente di identità; il presidente dell’ente provinciale del turismo dice che si può vivere di identità e tradizione in quanto i sardi sono speciali, sempre uguali a sé stessi. Il libro è scritto nel 2004, pochi anni dopo la legge regionale sull’identità sarda (legge regionale 26/1997) che l’antropologo di Guasila aveva criticato aspramente in quanto l’identità culturale dell’isola era considerata come qualcosa da valorizzare in solido, senza alcuna problematicità nel distinguere tra elementi positivi e negativi (Angioni 2000). Il console onorario danese, presente allo stesso evento, dice che “Assandira porterà in tavola l’identità dell’isola”, una espressione che mi ha ricordato una pagina di un menu della Costa Crociere – intitolato “Sardegna, orgoglio e fierezza anche nel piatto” – descrivente l’ambiente sardo come “sempre in equilibrio fra il selvaggio primitivo e la gentile accoglienza”, caratterizzato da “sapienti pastori” condotti da “ancestrali comportamenti che si ripetono uguali da generazioni”.
In più, nel libro sono presenti alcuni stereotipi negativi legati alla società pastorale sarda: gli incendi e la violenza. Lo stereotipo del pastore responsabile degli incendi estivi nel romanzo, come nella realtà, è veicolato dalle forze dell’ordine e dai media (“Hanno dato le colpe alla solita gente che appicca gli incendi e che i giornali chiamano piromani in agguato, chi sono non si sa”). Inoltre, Costantino Saru intrattiene i turisti raccontando episodi banditeschi di cui Grete esagera la violenza e i particolari cruenti. Nel libro, Mario si inventa una località vicina in cui sarebbe stato il bandito Tilocca; nel film a suggerirglielo è un “professore” suo consulente (“ce l’abbiamo un bandito? Abbiamo bisogno di un Mesina o di uno Stochino”). L’immaginario negativo legato al banditismo, dunque, può essere utilizzato e valorizzato per soddisfare la domanda di turisti e confermare la loro idea di Sardegna come terra fuori dalla civiltà. Giulio Angioni, anche poco prima della sua morte, si era espresso contro entrambi gli stereotipi sulla criminalità “tipica” sarda o meglio contro la tendenza mediatica a ricondurre determinati atti criminali entro lo schema “tradizionale” (2015, 2016).
Casualmente, l’uscita del film è avvenuta dopo un mese e mezzo di polemiche riguardanti la visione della Sardegna da parte degli italiani, entro il clima poco disteso segnato dall’aumento dei contagi da Covid nell’isola, in particolare nella Costa Smeralda, luogo principale delle vacanze per ricchi turisti del Nord Italia. Per ultima, la famigerata vignetta di Emilio Giannelli, pubblicata sul Corriere della Sera, raffigurante il Presidente della Regione come un pastore (bandito?) di fine Ottocento, difensore di un popolo di sardi-pecore contro gli “untori” continentali. Intorno a tale disegno si è scatenata l’usuale diatriba social tra gli “indignati” e i “minimizzatori”. Poco prima c’erano stati il gioiello di Pandora – a forma di pecora per rappresentare la Sardegna – e le dichiarazioni di Briatore su Arzachena conosciuta solo “da due pecore”, se non fosse stato per il suo locale. Ultimi episodi di una lunga serie in cui pastori e pecore sono stati utilizzati come emblema della nostra isola.
Perché offendersi? A mio parere l’equivoco nasce dalla confusione tra il significato che l’associazione pastori/pecore-Sardegna può avere per i sardi e quella che può avere per gli italiani. Di per sé, per un sardo può essere positivo (per chi proviene da famiglie pastorali) o indifferente (per chi, come me, ha tra i propri avi per lo più contadini), per i secondi è spesso negativo e con risvolti razziali. Il problema di incomprensione sorge in quanto si crede che ci debba essere un solo significato da applicare a una Sardegna monolite. La conseguenza è che si dibatte sul dito anziché sulla Luna: come questa nostra rappresentazione univoca sia il risultato di una subalternità politica, economica, culturale. Proprio perché interiorizzata da italiani e sardi appare anche in cose poco importanti, oppure è considerata banale, come se fosse normale e innocua. Possiamo provare brevemente a rispondere ai problemi posti dalla questione: qual è stato il reale peso della pastorizia nella storia sarda? Come mai ha avuto un ruolo complessivamente superiore a quello del Meridione d’Italia? Quando è nata una vera e propria distinzione tra pastori e contadini, come è stata costruita l’associazione pastori-identità sarda e la sua declinazione in senso razziale e “coloniale”?
La pastorizia nella storia economica sarda
Nel romanzo, al Presidente della Regione – presente anche lui all’inaugurazione di Assandira – viene fatta dire una frase molto significativa: “nell’isola la pastorizia è naturale: la chiede, la impone questa nostra terra a chi ci vive”. In realtà, la prevalenza dell’attività pastorale nel territorio sardo non si deve a una “naturale vocazione” della Sardegna ma è un prodotto di determinati processi storico-economici e dei rapporti di forza tanto nell’area euromediterranea quanto nell’isola.
Gian Giacomo Ortu (1988) aveva compiuto un primo calcolo approssimativo degli anni in cui – dal XII al XX secolo – nella nostra isola, era stata dominante l’agricoltura o la pastorizia: il risultato è stato di 500 anni per la prima e 400 per la seconda; l’equilibrio cambia in favore dei pastori, 400 a 250, partendo dalla metà del XIV secolo. Nel XIII, la Sardegna era il luogo da cui Pisa si riforniva di grano, la cui produzione intensiva – mai stata così ampia, specie nel Campidano – era dovuta alla presenza mercantile pisana e di altri stranieri; in particolare, vi era l’interesse a rifornire di risorse agricole un’area – come quella toscana – urbanizzata ma dall’agricoltura insufficiente. L’egemonia pastorale ha due genesi storico-economiche fondamentali: il ruolo della Sardegna entro il mercato mediterraneo in età moderna; l’avvento dei caseifici campani e laziali in età contemporanea. In età moderna, come ben illustrato già da Fernand Braudel (1986 [1949]), vi era una stabile domanda per il formaggio sardo nelle piazze europee, che lo richiedevano in quanto ottimo surrogato del sale; al contrario, il grano sardo era considerato di qualità inferiore rispetto a quello prodotto in altri Regni della Corona spagnola. Perciò le sue esportazioni sono avvenute a fasi alterne, legate all’interesse esterno e all’incentivazione della produzione cerealicola, correlati ai cali di questa in Sicilia, Napoli e regni d’Aragona (Anatra 1987, Tore 2004, Manconi 2010). La rigidità della domanda di formaggio e l’incertezza legata a quella di grano, crearono un forte incentivo all’utilizzo dei terreni per l’allevamento piuttosto che per la coltivazione; l’attività pastorale garantiva una rendita certa al feudatario che per tale destinazione affittava i territori di propria giurisdizione. La pastorizia consente l’arricchimento dei ceti feudali, rallentando il processo di modernizzazione dell’agricoltura (Ortu 1981). Per lo stesso motivo, unito al fatto che la pecora funzionava come motore della rifertilizzazione dei terreni, la pastorizia era il “settore determinante dell’azienda contadina” anche nelle aree prevalentemente agricole (Salice 2011).
Dalla metà del XVIII secolo, a partire dall’impostazione fisiocratica del riformismo sabaudo, si è di nuovo incentivata la produzione agricola che riprese a dominare sino all’ultimo quarto del XIX secolo; il pastore è ritenuto essere stretto in un sodalizio con il feudatario contro il governo sabaudo e i contadini, al fine di impedire lo sviluppo agricolo (Ortu 2017). In età contemporanea, dunque, la pastorizia si riaffermò nella nuova forma industriale capitalistica a causa della crisi agricola degli anni’90 dell’Ottocento, prodotta sia dalla svolta protezionistica del governo statale che dall’epidemia di fillossera che colpì la vite, mettendo in ginocchio l’imprenditoria vitivinicola (Di Felice 1998). I pascoli per l’allevamento ovino ripresero gli spazi, contro le coltivazioni, anche su impulso dei caseifici continentali, stabilitisi nell’isola al fine di produrre pecorino romano – trasformando il latte fornito dai pastori – diretto agli emigrati italiani in America (Di Felice 2011).
Sino al secondo dopoguerra – a causa della politica bellica, del protezionismo e del potere agrario – non vi furono le condizioni per riportare l’equilibrio in favore dello sviluppo agricolo. La legge De Marzi-Cipolla (1971), abbassando i canoni d’affitto, ha portato diversi proprietari a vendere i propri terreni, facendo così diventare i pastori proprietari e piccoli imprenditori, ponendo termine alla transumanza storica. Per quanto riguarda la modernizzazione della Rinascita e l’instaurazione dell’attuale settore zootecnico sardo, sino all’avvento della politica comunitaria europea e alle recenti crisi del prezzo del latte, rimando alla lettura di Sebastiano Mannia (2014).
La pastorizia nella costruzione razziale e coloniale del sardo
Seguendo il sociologo decoloniale Ramon Grosfoguel (2016), definiamo il razzismo come una gerarchia globale tra gli esseri umani, prodotta e riprodotta politicamente, culturalmente ed economicamente. Tale gerarchia può essere costruita in diversi modi, segnata lungo le linee del colore, dell’etnia, della religione, della cultura, distinguendo delle aree di essere/non essere o tra umano/non umano.
La razzializzazione dei sardi – da metà XVIII secolo a oggi – è stata definita tra l’etnia e la cultura. Le prime teorizzazioni sull’esistenza di una razza sarda (Mattone 1986) sono state elaborate nell’alveo degli studi naturalistici sul Nuovo Mondo, impregnati dal pensiero illuminista, il quale – come ci ha spiegato Mosse (2003, [1978]) – si proponeva di spiegare razionalmente le differenze umane partendo dall’influenza dell’ambiente sullo sviluppo delle razze. Francesco Cetti, scienziato naturale giunto nell’isola a seguito della riforma boginiana dell’Università, nella sua “Storia naturale di Sardegna” (1765-68) – ispirato dalle analoghe tesi di Buffon sugli indigeni americani – ipotizzò l’esistenza di una “razza sarda” estendendo agli esseri umani la sua idea di “impiccolimento” dei quadrupedi, determinato dal clima secco sardo che restringerebbe i corpi.
Oltre il determinismo geografico e climatico, sarà soprattutto a partire dalla metà del XIX secolo che l’appartenenza alla “razza” sarda verrà connessa a dei determinati comportamenti criminali e alla condizione di sottosviluppo economico; il contesto generale è quello del darwinismo sociale positivista, che piegò in termini razzisti le concezioni della “selezione naturale”, la “sopravvivenza” del più adatto e l’ereditarietà (Mosse cit., Brigaglia 2006). Il primo testo del razzismo “scientifico” sulla Sardegna fu un saggio di Paolo Mantegazza (1869), primo titolare di una cattedra di antropologia in Italia e membro della prima commissione parlamentare d’inchiesta sulla Sardegna; egli descrisse i sardi come caratterizzati da un’inerzia sconfiggibile solo dall’avvento della civiltà moderna, tramite la scuola e le ferrovie. Il coevo Cesare Lombroso (2013, [1876]) sosteneva che determinate caratteristiche fisiche fossero segni della degenerazione razziale, di una mentalità destinata al crimine; la ridotta capacità cranica dei sardi, dunque, ne segnalava lo stato selvaggio e la propensione all’uso del coltello e alla vendetta. Secondo il fondatore dell’antropologia criminale, erano le caratteristiche etniche del sardo (specie i suoi avi africani ed orientali) a causare la maggiore frequenza di omicidi nell’isola, non la condizione economica. Tra la fine del XIX e la prima metà del XX secolo, il razzismo si affermò come ortodossia accademica. I suoi principali esponenti erano allievi di Lombroso, fedeli all’idea del legame causale tra la genetica e il comportamento. Paolo Orano (1896) definì la società sarda come immobile, estranea alle conquiste della civiltà dato il suo isolamento; perciò i sardi sarebbero moralmente e biologicamente anemici, capaci di esprimersi solo in forme barbare. Alfredo Niceforo (1897), escludendo la causa economica, spiegò l’alta incidenza, nell’isola, di determinati reati quali omicidi, rapine e danneggiamenti con i fattori biologici del sardo, il “temperamento etnico regionale”: ogni varietà razziale, infatti, sarebbe caratterizzata da un suo reato specifico e i sardi sono predisposti al delitto di sangue. Tale condizione della società sarda sarebbe il risultato di un’atrofia nell’evoluzione sociale verso la civiltà, determinante un arresto nello sviluppo psichico, a causa dell’isolamento; la Sardegna viene dunque inserita tra i “popoli primitivi” e le “razze inferiori” il cui ciclo di sviluppo non si è completato. Giuseppe Sergi (1907), autore di studi sulla “varietà umana microcefalica mediterranea” dei sardi, detti “pigmei d’Europa”, sosteneva che i sardi fossero rimasti immutati, nei propri caratteri, dal Neolitico, più vicini alla natura che alla civiltà; la psicologia del sardo è quella del primitivo, le sue concezioni mentali sono ristrette, egoistiche e sentimentali.
Ad accomunare gli antropologi citati è il loro bersaglio principale: il pastore errante, in quanto rappresentante autentico della sardità arcaica e nemico principale del progresso dell’isola: “Quando la cresciuta civiltà avrà cancellato dalla Sardegna il pastore errante, quell’isola sarà uno dei due paesi più morali al mondo”, “Il pastore errante (…) è la rovina alla Sardegna; spesso è sinonimo di ladro” (Mantegazza 1869); “Chi del resto più selvaggio del pastore nomade (…) fuori dal dominio delle leggi, della moralità (…) dal consorzio umano?”, “Il vento reca larghe esalazioni di pastorizia, di latte, di pelli, di selvaggio (…) una civiltà morta e una barbarie che risale alla preistoria (…) Chi sono insomma questi pastori nomadi che vivono errando come gli antichissimi umani (…) senza sentire nulla di elevato?” (Orano 1896); “Quegli uomini si sono così atrofizzati nelle usanze dei tempi passati, che tenacemente indossano il costume del loro paese e vestono di lunghe pelli di capre. C’è una specie di resistenza ostile a tutto ciò che viene dall’esterno (…) essi non vogliono mutare; mentre tutti mutano intorno a loro, essi rimangono fossilizzati negli usi e nei costumi del passato; “…noi chiamiamo ciò non adattabilità della razza, impossibilità di progredire, di evolversi (…) è popolazione che non può o non vuole prendere parte alla grande e meravigliosa costruzione della civiltà attuale”; “La zona delinquente della Sardegna è un vecchio strato sociale che galleggia nella attuale società con tutti i sentimenti primitivi del suo tempo arcaico; è lo stato sociale dei popoli pastori, agitato da istinto belligero e aggressivo, stato sociale che la rimanente società ha già da lunga pezza oltrepassato (Niceforo 1897); “Quel pastore che vive per anni solitario sulla pianura coi suoi animali, o sui monti ove si ritira d’estate pei pascoli, lontano dall’uomo che ha abitudini sociali e contatti continui con ogni classe di persone (…) Noi abbiamo l’abitudine di definire il sardo come primitivo; è meglio di definirlo come naturale (…) Qui tutto è naturale, e l’uomo qui vive come la natura esige e come egli stesso si adatta”; “…l’anima sarda è rimasta così come era d’origine, come all’epoca della pietra, e come è rimasta gran parte dell’isola, pastorizia, nomadismo d’estate e d’inverno”; “…è facile comprendere che quella che si chiama civiltà (…) non può essere un attributo del pastore sardo” (Sergi 1907).
Stabilire un nesso causale tra l’appartenenza razziale e la delinquenza “tipica” sarda, in quell’epoca, aveva un significato molto preciso. Gli anni’90 dell’Ottocento sono stati caratterizzati, come su riportato, dalla crisi agricola provocata dalla politica protezionista statale; è in questa situazione di disagio economico – entro la quale furono numerose le perdite dei terreni per debito d’imposta (Atzeni 2000) – che si è assistito alla recrudescenza del banditismo. Il razzismo positivista, spostando l’attenzione sulle caratteristiche intrinseche dei sardi, allontanò la ricerca di dirette responsabilità politiche e – allo stesso tempo – fornì una giustificazione ideologica per azioni repressive particolarmente efferate, in cui furono colpite intere comunità piuttosto che i banditi, come nella spedizione militare inviata nell’isola nel 1899 (Bechi 1997, [1914]), dato che il banditismo è espressione della inferiorità razziale della popolazione. Inoltre, l’isola è ormai inserita entro il mercato e lo sviluppo capitalistico italiano in condizione di colonia interna: il differente grado di sviluppo tra l’isola e l’Italia, specie il Nord-Ovest, è sfruttato dal capitale esterno (dalle miniere ai caseifici sino all’industria molitoria) a proprio profitto (Di Felice 1998), entro l’ordinamento istituzionale italiano. La subalternità alla politica economica governativa ostacolò la crescita di un’imprenditoria agricola: il protezionismo, sostenuto da una coalizione di interessi tra il governo, gli industriali settentrionali e gli agrari meridionali danneggiò l’agricoltura più produttiva e diede un contributo decisivo all’allargamento del divario tra le due parti dello Stato Unitario (Felice 2015); l’ingresso nella Grande Guerra interruppe la ripresa economica avviatasi grazie alle migliorie, in campo agricolo, previste dalla legislazione speciale. Far ricadere le cause del sottosviluppo economico alle caratteristiche razziali di sardi e meridionali ha una chiara funzione politica, come già riconosciuto a suo tempo da Gramsci (1966, [1930]), comprensibile entro la funzione del razzismo come “pilastro ideologico” del “capitalismo storico”, volto a giustificare la diseguaglianza nella divisione internazionale del lavoro (Wallerstein 1983). Perciò ritengo che il razzismo antisardo sia stato un discorso coloniale (Bhabha 1994): un apparato di potere che gira intorno al riconoscimento/disconoscimento di differenze razziali/culturali/storiche, la cui funzione strategica predominante è quella di creare uno spazio per i popoli soggetti attraverso la produzione di saperi; il suo obiettivo è di costruire il colonizzato come una popolazione degenerata sulla base dell’origine razziale, al fine di giustificare il dominio.
Per capire come mai il pastore sia al centro di questa costruzione razziale-coloniale dell’identità sarda bisogna ritornare alla metà del Settecento. Il riformismo sabaudo, intenzionato a restringere il potere feudale e a valorizzare le risorse isolane, a partire dalla riforma delle Università diede un grande impulso alla volontà di conoscere la realtà sarda, entro un generale progetto di modernizzazione (Mattone, Sanna 2007). Quest’ultimo, data l’egemonia intellettuale della fisiocrazia, era orientato alla crescita dell’agricoltura, principale fonte della ricchezza. Francesco Gemelli (1776) inaugura gli studi animati dalla volontà di migliorare la produzione agraria, che dovrebbe essere razionalizzata attraverso la garanzia della proprietà, con la chiusura dei fondi, contro il sistema comunitario delle terre, individuato come la “radice infetta” causa dei mali dell’agricoltura e dunque dell’economia sarda. Tra la fine del XVIII e la metà del XIX la pastorizia viene gradualmente individuata come il nemico principale dello sviluppo delle campagne, dal momento in cui l’uso di pascoli sottrarrebbe i terreni alla coltivazione intensiva e alla garanzia della proprietà privata. Con i provvedimenti dell’Ottocento volti a consolidare quest’ultima “il pregiudizio ideologico diventa legge” (Ortu 2017). Tuttavia, sia Gemelli che la Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, fondata nel 1804, non erano nettamente ostili all’attività pastorale: il primo proponeva di migliorare i pascoli, chiudendoli per promuovere un allevamento intensivo delle greggi; nei rapporti della seconda si evince la volontà di conciliare contadini e pastori, proponendo anche di potenziare il settore laniero per sottrarlo al mero autoconsumo (Maurandi 2001). Per questo, le “Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna” di Carlo Baudi di Vesme (2004, [1848]) segnano una netta discontinuità con gli studi precedenti, essendo tanto avverse alla pastorizia da proporre un aut aut: “i pastori sono la classe di persone più difficile a incivilire e a ridursi a non turbare la vita sociale (…) la pastorizia è incompatibile con l’agricoltura; conviene vedere caduta l’una o l’altra: né può essere dubbia la scelta”. Da un lato, a portarlo a questa drastica conclusione, è la sua esperienza personale diretta di proprietario di un podere-modello, scontratosi e perdente in un contenzioso legale contro delle grandi aziende pastorali, invadenti il suo fondo (Salice 2015a); d’altra parte non si può non collocare il suo pensiero entro l’imminente Fusione Perfetta (1847) da lui propugnata. Baudi di Vesme riconosce la diversità etnoculturale dei sardi e ritiene necessaria – e benefica per gli stessi – la loro italianizzazione: la lingua sarda è dunque un ostacolo alla piena integrazione dell’isola nel regno continentale e al suo inserimento entro una lega doganale italica. Siamo già entro una linea di pensiero comune alla costruzione dei nazionalismi di Stato – e alle connesse esigenze del nascente capitalismo industriale – che anticipa, anche sul piano ideologico, la questione meridionale: la dicotomia pastori-contadini sta dentro una geografia immaginaria europea Nord-Sud che l’Italia riprodurrà al suo interno, associando al primo polo il carattere modernizzante e al secondo quello dell’arretratezza.
Se i pastori incarnano la sardità più autentica e rappresentano l’avversario principale delle riforme economiche, la distanza da essi determina il proprio grado di adesione alla civiltà europea e al progetto modernizzatore della monarchia. In questo senso credo si possa affermare che l’italianità appaia come un tramite per l’europeizzazione: i membri dell’élite sarda riproducono questa ideologia anti-pastorale, al fine di mostrarsi allo stesso livello dell’élite europea e piemontese, sposando la politica governativa. Un esempio significativo ci viene fornito da Vittorio Angius e Giuseppe Manno, tra i padri della storiografia sarda, che inventò il “mito della nazione sarda” e sostenne l’italianità della Sardegna ricongiuntasi, grazie ai Savoia, alla sua patria naturale (Accardo 1996). Essi danno credito alla ricostruzione falsa della fine della colonizzazione greca di Montresta, provocata dai pastori che avrebbero ucciso i coloni per appropriarsi dei loro territori. Tale racconto poté imporsi come vero solo entro uno schema di valori legittimante il riformismo sabaudo: lo scontro tra pastori sardi e coloni greci è l’emblema dello scontro tra barbarie e civiltà; conferma la necessità di modernizzare un contesto ancora “arretrato”, a causa delle conseguenze del malgoverno spagnolo cui la modernizzazione sabauda porrà rimedio (Salice 2015b, 2015c).
L’identificazione tra italianizzazione e modernizzazione è presente con forza a partire dal secondo dopoguerra, con l’industrializzazione passiva spinta dai Piani di Rinascita (Mongili 2015). Screditato il razzismo scientifico basato sulla biologia, a segnare la gerarchia ora è la cultura. Così, la spiegazione culturalista del sottosviluppo, basata sul “capitale sociale”, impregna l’ideologia della classe politica sarda e italiana coinvolta nel nuovo progetto modernizzatore: il pensiero socioantropologico struttural-funzionalista dominante nega alla società tradizionale – definita, significativamente, in termini delle proprie mancanze rispetto alle società civilizzate – intrappolata nella povertà, la possibilità di evolvere indipendentemente, essendo funzionante come un organismo che mira a preservarsi e il cui comportamento individuale è diretto al mantenimento dell’ordine sociale. Un esempio di questa teoria è il famoso libro di Antonio Pigliaru sul codice della vendetta barbaricina (2006 [1959]), il quale svolgerebbe appunto la funzione di sanzionare chi viene meno alla fedeltà comunitaria, una base di certezza in un contesto naturale avverso. L’altro è sicuramente “La famiglia esclusiva” (1971), scritto dal sociologo Luca Pinna per la Regione, che gli commissionò uno studio sulle resistenze allo sviluppo economico programmato dalla Rinascita. Ispirato alla teoria del familismo amorale di Banfield (1958), scrisse che in Sardegna il nucleo familiare sarebbe l’unica struttura sociale in cui le persone soddisfano ogni aspettativa esistenziale; la solidarietà, perciò, si esprime solo entro essa, manifestando ostilità verso gli altri gruppi; il comportamento verso gli estranei è descritto come individualista e opportunista, privo di rispetto per i beni altrui.
Ancora una volta è il pastore l’emblema della sardità, intesa negativamente come ostacolo allo sviluppo economico. La relazione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna (1972) – che diede un importante contributo alla legittimazione della creazione di un polo industriale nella Sardegna centrale, volto a trasformare la società barbaricina – del Senatore Giuseppe Medici ci mostra chiaramente questo pensiero: un’idea di Sardegna storicamente immobile e della pastorizia come l’ambiente culturale generatore del banditismo; il pastoralismo porterebbe all’esasperazione “elementi psicologici congeniali con la gioventù rurale barbaricina”; la pastorizia in Sardegna è “naturale”, imposta dall’ambiente fisico ed economico sociale, dunque necessario intervenire per la sua trasformazione.
Come uscirne. Colpa di chi?
Dagli anni’80 a oggi, anche grazie al declino e al superamento internazionale delle teorie socio-antropologiche succitate, numerosi studi sociali e storici hanno mostrato come il “pastore sardo” dell’immaginario identitario e stereotipato sulla Sardegna sia per lo più un’invenzione. Difficile distinguere nettamente tra pastori e contadini prima della specializzazione avvenuta durante l’età contemporanea, essendo esistite aziende rurali svolgenti entrambe le attività e in cui l’allevamento delle pecore era comunque funzionale anche alla stessa agricoltura (Salice 2011). Non è mai esistito un pastore “isolato”: la transumanza, al contrario, rendeva necessario ai pastori stringere dei legami lungo il cammino, permettendo la circolazione sia di beni che di idee (Ortu 1988); né il pastore era un individualista o un familista esclusivo/amorale ma era solito cooperare e solidarizzare al di fuori della famiglia nucleare (Meloni 1984, Caltagirone 1989, Maxia 2005); né il pastore era incapace di adattarsi, organizzarsi e rielaborare la propria attività sulla base dei cambiamenti (Solinas 1990, Mannia 2014).
Tuttavia, nello stesso periodo, in Sardegna abbiamo assistito all’emergere di una nuova concezione dell’identità sarda, che in parte ribalta la visione negativa egemone nei decenni precedenti. L’identità sarda diventa strumento di legittimazione politica e valorizzazione economica: “lo Stato (…) e il capitale (nella fattispecie quello turistico)” costruiscono e usano “rappresentazioni dell’identità in funzione dei loro interessi” (Deiana 2005). Si tratta di un processo – generato dalla crisi e fallimento della Rinascita negli anni’70 oltre che dall’ascesa della globalizzazione e dell’europeismo – coinvolgente tanto la politica quanto l’economia. Nel primo caso, abbiamo sia un neosardismo volto a esaltare la “costante resistenziale” e a vedere in una mitizzata società pastorale la base per un processo rivoluzionario e la costruzione di una società egalitaria (Simon Mossa 2012 [1967], Spiga 1968), sia l’elaborazione di un discorso volto alla legittimazione di una classe politica privata dell’ideologia della Rinascita e bisognosa di giustificare il proprio ruolo di mediazione con lo Stato centrale. Entro tale strategia della classe dirigente si collocano la legge regionale 26/1997 sulla valorizzazione dell’identità sarda o l’istituzione di una Sa Die de sa Sardigna (legge regionale 44/1993) entro una narrazione storica anti-piemontese eliminante il conflitto di classe interno alla società sarda (Caltagirone 2005) e oggi per lo più esaltante una fantomatica “sardità”, slegata dagli eventi storici cui la celebrazione si richiama. Per quanto riguarda l’aspetto economico, nell’isola – in conformità con l’espansione della “industria turistica” in un’Europa Occidentale avviata a deindustrializzarsi (D’Eramo 2017) – l’identità diventa una merce da vendere a turisti forestieri intenzionati a confermare la propria immagine stereotipata di una Sardegna esotica, arcaica, arretrata. Il turismo è la manifestazione più evidente di come gli stessi sardi contribuiscano alla produzione di una determinata immagine di sé stessi, promuovendo la propria presunta “unicità” e “autenticità” all’esterno. L’interno “selvaggio” è – con le coste “incontaminate” – uno dei due poli del “mondo del desiderio turistico” della Sardegna (Clemente 2015); negli anni’90, con la proposta del Parco Nazionale del Gennargentu si cercò pure di valorizzare come “green” questa arretratezza naturale delle zone interne proteggendola dai suoi stessi abitanti – i pastori – cui era imputato anche il deterioramento ambientale e il fallimento del progetto ecologista, a causa della loro ennesima resistenza alle iniziative modernizzatrici statali (Heatherington 2010).
L’antropologo Gino Satta (2000) si soffermò su tale immagine in un lavoro ormai classico sul turismo a Orgosolo come emblema della “vera Sardegna”, sede di un “repertorio” di temi costruiti storicamente sull’isola, da spettacolarizzare per la promozione turistica: isolamento, arcaismo, resistenza, banditismo, vendetta, abigeato. Il pastore-bandito è il simbolo, ricercato tanto dai viaggiatori ottocenteschi come dai turisti contemporanei alla ricerca di un “pranzo tipico” venduto loro come “tradizionale”, inscritto in un passato atemporale appositamente inventato. Un aspetto interessante del libro è la sua decostruzione del mito della “ospitalità” sarda, utilizzato dalla pubblicità turistica e derivante dallo sguardo implicitamente razzista della letteratura di viaggio del XIX secolo: “l’ospitalità si presta a rappresentare la differenza tra i viaggiatori civilizzati e i sardi primitivi, stabilendo tra di loro una implicita gerarchia”.
Si tratta di un esempio significativo di quanto i sardi si possano compiacere, trasformando in “positivo”, un carattere attribuitogli al fine di segnarne l’inferiorità razziale. Così è noto che una parte di sardi si riconosca nella mitologia della Brigata Sassari (Fois 1981), utilizzata ampiamente dalla propaganda militarista e dalla classe politica, la cui base è il razzismo ottocentesco: il sardo (pastore) particolarmente adatto al combattimento all’arma bianca, in quanto selvaggio è privo delle inibizioni delle civiltà e dunque predisposto al contesto bellico più dei soldati provenienti dalle aree civilizzate dello Stato; un sardo – e precursore del sardismo – come Attilio Deffenu (1918) contribuì, a servizio dell’Esercito, all’elaborazione e diffusione di tale ideologia. In tempi più recenti, abbiamo assistito a un’identificazione di molti sardi con i pastori, tra il mito e il reale: “Siamo tutti pastori” è stato uno slogan utilizzato durante le proteste dello scorso decennio – contro il calo del prezzo del latte – in cui i pastori sono emersi anche su altre categorie in lotta. Si trattava di manifestare la propria solidarietà con i membri di un settore carico di significato “identitario”; del resto, il Movimento Pastori Sardi mostrò la capacità di costruire un discorso su sé stesso, utilizzando i discorsi sul pastoralismo come “risorse simboliche e identitarie” per promuovere la propria azione sul campo politico ed economico, ridefinendo la propria identità attraverso la resistenza e la rivolta (Pitzalis, Zerilli 2013).
Quindi, se anche dei sardi contribuiscono a questa rappresentazione identitaria negativa, significa che è “anche colpa nostra”? Una simile opinione sembra una manifestazione di “blaming the victim”: incolpare la vittima. L’espressione viene dal titolo del celebre libro di Ryan (1976) contro il “processo ideologico” volto a ricondurre la povertà ai difetti dei poveri, piuttosto che sulle cause strutturali della diseguaglianza, finendo dunque per difendere lo status quo. Se la “colpa” è “innanzitutto nostra” significa che il problema potrebbe essere risolto tramite un “nostro” cambio di atteggiamento. Tuttavia, se, come abbiamo visto, lo stereotipo negativo del pastore su cui si è fondata l’identità sarda ha un fondamento razzista e coloniale interno, la “colpa” non va certo ricercata nei razzializzati/colonizzati sardi. Più che attribuire colpe individuali – siano esse sarde o italiane – ed emettere contraddittorie condanne collettive, dovremmo comprendere le condizioni che consentono la continua riproduzione di un’ideologia simile e quindi cercare di cambiarle. Senza effettuare questa operazione, l’idea della “colpa nostra” è una falsa responsabilizzazione che occulta i reali rapporti di forza in seno a questo Stato; in più, nega l’esistenza del razzismo – più o meno consapevole – contro i sardi, assolvendo così i razzisti, il che non è tollerabile per ovvie ragioni.
L’identità si costruisce sempre in relazione a un “altro”. Nel nostro caso, si è costruita in rapporto ai centri più sviluppati d’Europa, entro la geografia immaginaria Nord-Sud del XVIII secolo che si è riprodotta entro la costruzione dello Stato unitario italiano nel XIX secolo (Moe 2002, Patriarca 2010). A prescindere dalla multipolarità della nostra costruzione identitaria, è necessario comprendere come tanto i sardi quanto gli italiani settentrionali siano situati. Per poter superare la rappresentazione negativa della Sardegna, dunque, è necessario soffermarsi sulla relazione asimmetrica tra quest’ultima e i centri del potere politico, economico e culturale; finché questa sarà esistente, non solo ci saranno “anche” dei sardi a rappresentarsi in un certo modo ma un eventuale cambio di rappresentazione da parte “nostra” non avrà comunque effetto sull’immaginario italiano.
Riferimenti bibliografici citati
Aldo Accardo, La nascita del mito della nazione sarda, AM&D 1996
Bruno Anatra, La Sardegna dall’unificazione aragonese ai Savoia, UTET 1987
Giulio Angioni, Pane e formaggio e altre cose di Sardegna, Zonza Editori 2000
Giulio Angioni, Assandira, Sellerio 2004
Francesco Atzeni, Riformismo e modernizzazione. Classe dirigente e questione sarda tra Ottocento e Novecento, FrancoAngeli 2000
Edward C Banfield, The Moral Basis of a Backward Society, The Free Press 1958
Carlo Baudi di Vesme, Considerazioni politiche ed economiche sulla Sardegna, Ilisso 2004
Giulio Bechi, Caccia grossa, Ilisso 1997
Benedetto Caltagirone, Animali perduti. Abigeato e scambio sociale in Barbagia, Celt1989
Benedetto Caltagirone, Identità sarde. Un’inchiesta etnografica, CUEC 2005
Homi Bhabha, The Location of Culture, Routledge 1994
Fernand Braudel, Civiltà e Imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II, vol.I, Einaudi 1986
Manlio Brigaglia, “L’isola ‘nature’ fra viaggiatori e antropologi” in M.Brigaglia, A.Mastino, G.G.Ortu, Storia della Sardegna vol.II, Laterza 2006
Francesco Cetti, Storia naturale di Sardegna, Ilisso 2000
Pietro Clemente, “Un’isola nell’isola. Un bricolage antropologico con pezzi di Costa Smeralda” in L.Marrocu, F.Bachis, V.Deplano, La Sardegna. Idee, luoghi, processi culturali, Donzelli 2015
Alessandro Deiana, “Identità esibite. I gruppi folkloristici” in G.Angioni, F.Bachis, B.Caltagirone, T.Cossu Sardegna. Seminario sull’identità, CUEC 2005
Attilio Deffenu, «Relazione sui mezzi più idonei di propaganda morale da adottarsi fra le truppe della Brigata», 1918
Marco D’Eramo, Il selfie del mondo. Indagine sull’età del turismo, Feltrinelli 2017
Maria Luisa Di Felice, “La storia economica dalla fusione perfetta alla legislazione speciale (1847-1905)”, in La Sardegna – le Regioni dall’Unità d’Italia ad oggi, Einaudi 1998
Maria Luisa Di Felice, “La rivoluzione del pecorino romano. Modernità e tradizione nell’industria casearia sarda del primo Novecento” in La pastorizia mediterranea, a cura di Antonello Mattone e Pinuccia Simbula, Carocci 2011
Emanuele Felice, Ascesa e declino. Storia Economica d’Italia, Il Mulino 2015
Giuseppina Fois, Storia della Brigata Sassari, Gallizzi 1981
Francesco Gemelli, Rifiorimento della Sardegna proposto nel miglioramento della sua agricoltura, 1776
Antonio Gramsci, “Alcuni temi della quistione meridionale” in La questione meridionale, Editori Riuniti 1966
Ramon Grosfoguel, “What is racism?” in Journal of World System Research, vol.22, 2016
Tracey Heatherington, Wild Sardinia. Indigeneity and the global dreamtimes of environmentalism, University of Washington 2010
Cesare Lombroso, L’uomo delinquente, Bompiani 2013
Francesco Manconi, La Sardegna al tempo degli Asburgo, Il Maestrale 2010
Sebastiano Mannia, In tràmuta. Antropologia del pastoralismo in Sardegna, Il Maestrale 2014
Paolo Mantegazza, Profili e Paesaggi di Sardegna, Brigola 1869
Antonello Mattone, “I sardi sono intelligenti?”, Archivio Storico Sardo 1986, vol.35, n.3
Antonello Mattone, Piero Sanna, Settecento sardo e cultura europea, FrancoAngeli 2007
Pietro Maurandi (a cura di), Memorie della Reale Società Agraria ed Economica di Cagliari, Carocci 2001
Carlo Maxia, Filadas. Caprari nel Gerrei, CUEC 2005
Benedetto Meloni, Famiglie di pastori, Rosenberg&Sellier 1984
Nelson Moe, The view from Vesuvius. Italian culture and the Southern Question, University of California Press 2002
Alessandro Mongili, Topologie postcoloniali. Innovazione e modernizzazione in Sardegna, Condaghes 2015
George L Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Laterza 2003
Alfredo Niceforo, La delinquenza in Sardegna, Sandron 1897
Paolo Orano, Psicologia della Sardegna, Tipografia della Casa Editrice Italiana 1896
Gian Giacomo Ortu, L’economia pastorale della Sardegna moderna, Edizioni della Torre 1981
Gian Giacomo Ortu, “La transumanza nella storia della Sardegna” in Mélanges de l’école française de Rome, 1988, n.100-2
Gian Giacomo Ortu, Le campagne sarde tra XI e XX secolo, CUEC 2017
Silvana Patriarca, Italianità. La costruzione del carattere nazionale, Laterza 2010
Antonio Pigliaru, Il codice della vendetta barbaricina, Il Maestrale 2006
Luca Pinna, La famiglia esclusiva, Ilisso 2010
Marco Pitzalis, Filippo M.Zerilli, “Pastore sardu no t’arrendas como. Il Movimento Pastori Sardi: alterità, resistenza, complicità” in Rassegna Italiana di Sociologia, n.3, 2013
William Ryan, Blaming the victim, Vintage Books 1976
Giampaolo Salice, Dal villaggio alla nazione, AM&D 2011
Giampaolo Salice, “Carlo Baudi di Vesme” in C.Novelli, S.Ruju, Dizionario degli imprenditori di Sardegna, Aipsa 2015a
Giampaolo Salice, Colonizzazione sabauda e diaspora greca, Sette Città 2015b
Giampaolo Salice, “The Greek mirror: philellenism and southern italian patriotisms 1750-1861” in Journal of Modern Italian Studies – n.4, vol.20, 2015c
Gino Satta, Turisti a Orgosolo. La Sardegna pastorale come attrazione turistica, Liguori Editore 2000
Olivetta Schena, Sergio Tognetti, Commercio, finanza e guerra nella Sardegna tardomedievale, Viella 2017
Giuseppe Sergi, La Sardegna. Note e commenti di un antropologo, Bocca 1907
Antonio Simon Mossa, Le ragioni dell’indipendentismo, Alfa Editrice 2012
Piergiorgio Solinas, Pastori sardi in provincia di Siena, Università degli Studi di Siena (1990)
Eliseo Spiga, Sardegna: rivolta contro la colonizzazione, Feltrinelli 1968
Gianfranco Tore, “Monarchia ispanica, politica economica e circuiti commerciali” in B.Anatra, G.Murgia, Sardegna, Spagna e Mediterraneo, Carocci 2004
Immanuel Wallerstein, Historical Capitalism, Verso 1983
Giulio Angioni su Il Manifesto Sardo (2015, 2016):
https://www.manifestosardo.org/contorni-fatti-orune-nule-codice-della-vendetta-leducazione-dei-giovani/. ]https://www.manifestosardo.org/piromani-in-agguato/.



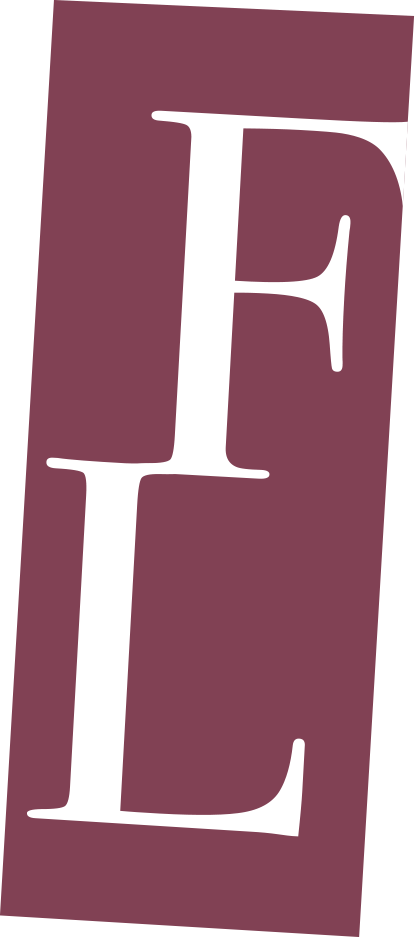

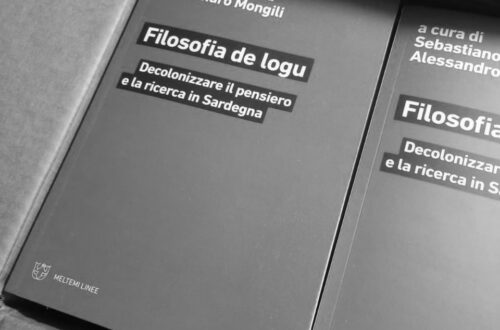

2 commenti
CGarau
Articolo alquanto discutibile, per usare un eufemismo. Qui si cerca di riabilitare un personaggio che, della visione colonizzata italo-centrica della Sardegna e della sua cultura (ovvero quella contro la quale si scaglia, in teoria, il manifesto di questo sito), è sempre stato uno dei più forti sostenitori, ovvero Giulio Angioni. Scrivere che Angioni fosse un “antropologo molto critico verso l’ossessione identitaria degli ultimi decenni come dei luoghi comuni sui pastori sardi, facenti da perno alla sardità immaginata” è una falsificazione, per quanto egli stesso cercasse, ovviamente, di presentarsi in quella maniera (così come fanno i suoi imitatori odierni).
Angioni non era contrario all’identità sarda in quanto “ossessiva” o “immaginata”, era contrario all’identità sarda in quanto sarda. Non aveva alcun problema nell’identificarsi come italiano quando gli si facevano domande sulle sue scelte in campo linguistico, così come non vedeva alcun problema con i soliti, moltissimi doppi standard tra situazione sarda e situazione italiana e nel trattamento riservato alle rispettive culture (anche questa caratteristica comune con alcuni accademici e “intellettuali” sardi di vario genere).
È un personaggio che ha combattuto per anni contro qualsivoglia forma di ufficializzazione della lingua sarda e di un suo utilizzo che non fosse limitato al folklore (basti pensare che, nel gruppo di coloro i quali, a suo parere, rappresentavano la “nouvelle vague letteraria sarda”, egli ha escluso totalmente gli autori in sardo), così come contro ogni forma di attivismo politico indipendentista o anti-colonialista in Sardegna. In sostanza, lui è stato parte del problema, e il suo (insieme a quello dei suoi sodali) combattere contro ogni visione della cultura sarda che non fosse qualcosa di vecchio e destinato a sparire ha contribuito in larga parte alla sua folklorizzazione. Angioni voleva che la cultura sarda sparisse, non che venisse salvata dal folklore. E accusare tutto ciò che fosse sardo di essere posticcio è quello che ha fatto per decenni. Mereu è un grande regista, e sicuramente il suo film sarà fatto benissimo, così come tutti gli altri che ha diretto (ed è probabile che sia in grado di trasmettere un messaggio molto migliore dell’originale), ma il libro da cui è stato tratto, così come tutta la produzione di Giulio Angioni, non merita certo di essere preso come base per un ragionamento serio sul futuro della Sardegna.
admin
Gentile lettore, il tuo commento è stato pubblicato, ma è piuttosto fuori luogo per almeno due ragioni:
1) sposta il focus da un tema complesso e di lunga durata (la razializzazione dei sardi e la questione del pastoralismo) a una questione personale, usando un banale argumentum ad personam (il tema dell’articolo non è Giulio Angioni, tanto meno le sue posizioni politiche, che c’entrano poco o nulla);
2) muove accuse gravi, ma generiche e non argomentate, all’autore dell’articolo e nel complesso a tutta Filosofia de Logu.
Non è il modo corretto di procedere, almeno in questa sede. Questo sito non è un social e le dinamiche social devono restarne fuori. Sono ben accetti tutti i commenti, ma vanno argomentati adeguatamente e devono restare nel merito degli articoli a cui si riferiscono. Non sono ammissibili sfoghi personali, polemiche strumentali, illazioni, spostamenti indebiti di focus. E anche il linguaggio deve essere moderato.
Confidiamo che questo richiamo sia ben compreso e interiorizzato da chiunque voglia interloquire con FdL in questo spazio.